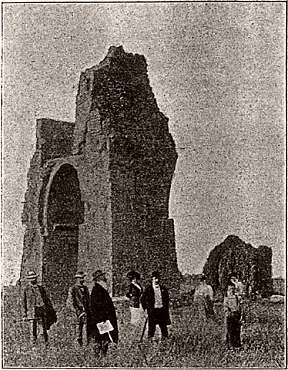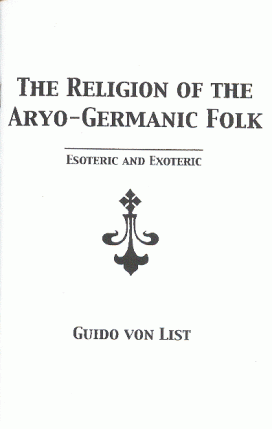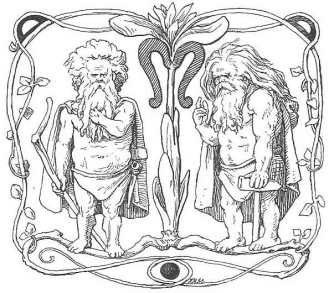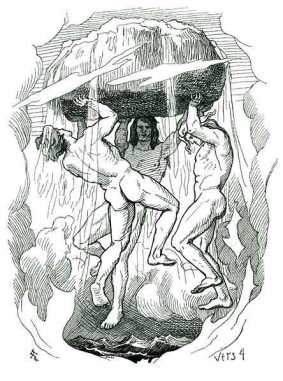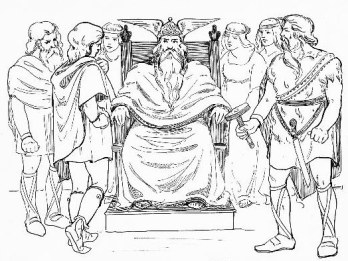Seguendo il suggerimento di un amico, caro e competente, ho letto i due splendidi libri di Lady Gregory sulla mitologia dei Celti, e, così di primo acchito e senza troppo pensare due considerazioni iniziali mi vengono in mente.
La prima di queste considerazioni è che, leggendo le storie e le avventure di Cuchulain di Muirthiemne e la storia dei Tuatha de Danaan, in una certa misura continuiamo a rileggere l’eterna storia di Gilgamesh, dal momento che tutta l’epica celtica che conosciamo, o almeno che io conosco, si basa sulla ricerca dell’immortalità, intesa come raggiungimento della perfezione, e sul cammino irto di ostacoli, che tutti, uomini e dei, devono affrontare per raggiungerla.
Naturalmente esistono differenze tra la mitologia celtica e quelle dei paesi mediterranei o dell’Asia Minore, ma, dal momento che si tratta sempre e comunque di popolazioni indoeuropee, è possibile trovare una solida base comune in tutti i loro miti, a prescindere dalle numerosissime differenze e particolari che le distinguono una dall’altra e che si riferiscono a popolazioni con usi e costumi diversi.
Senza analizzare i miti mesopotamici in profondità, vorrei solo notare come sia i Sumeri che i Babilonesi basassero la loro religione sulla fede in una dea madre, una grande dea, madre di tutto quanto esiste, e come a questa dedicassero i più grandi onori e cerimonie.
I miti di Ishtar e Tammuz, Inanna e Dumuzi in Mesopotamia, Iside e Osiride in Egitto, Afrodite e Adone in Grecia ripetono tutti il mito primigenio della madre, esistente da sempre, che crea l’universo intero, lo foggia e lo mantiene in vita, resuscitandolo ad ogni stagione. Dee Madri, Veneres, o dee della vegetazione rappresentano tutte lo stesso principio, come si ritrova anche nella grande dea, rappresentata dalla triade divina, nella mitologia celtica.
La leggenda di Gilgamesh, il suo viaggio in territori sconosciuti per raggiungere il paradiso in cui vive l’uomo eterno, Uthnapishtin, colui che si è salvato dal diluvio, e che non raappresenta altro che il cammino iniziatico dell’uomo per raggiungere la salvezza e la felicità eterna, è ripetuta innumerevoli volte nelle leggende irlandesi e gallesi sulle quali si fonda la conoscenza attuale della religione dei Celti, naturalmente con particolari diversi dovuti alla loro diversa concezione della vita.
Gli eroi celtici compiono il loro viaggio iniziatico alla ricerca del “calderone di Karidwen”, che può offrire l’abbondanza, sanare le ferite e in casi estremi riportare un morto alla vita: non molto dissimile dal “paradiso” e dall’immortalità ricercati da Gilgamesh.
La seconda considerazione che mi sorge immediatamente nella mente è che, al contrario delle tradizioni egizie, ebraiche e greco-romane, non esistono presso i Celti miti di creazione: il mondo esiste, non viene creato da una divinità, femminile presso i popoli asiatici almeno in origine, femminile anche presso le popolazioni ebraiche, che però molto prima degli altri popoli la trasformarono in un dio maschile, androgina presso gli Egizi, in modo da includere i due poli naturali della vita.
Questa, vale a dire l’assoluta mancanza di miti di creazione, è la sostanziale differenza tra la concezione del divino tra i celti e gli altri popoli, sia asiatici che mediterranei, e sarebbe bene aggiungere a questi anche le popolazioni germaniche.
Comprendere la religione dei Celti comporta numerose difficoltà, la prima delle quali può essere accordare l’idea di un pantheon estremamente vario e popolato da circa quattrocento divinità con l’idea base di un unico principio divino. Per far questo bisogna rinunciare alle comuni categorie di giudizio tipiche della tradizione culturale dell’Occidente, che sono il frutto dell’incontro tra il pensiero classico e quello giudeo-cristiano. Per farlo dobbiamo imporci di pensare il divino in termini di incessante evoluzione, cosa questa che esclude la possibilità di porre in rapporto antitetico materia e spirito, così come, contemporaneamente, include l’essere umano in un processo evolutivo analogo a quello seguito dalla divinità.
Questo permette di spiegare il motivo per cui presso i Celti non esistessero miti di creazione, perché tutte le esistenze “in corso”, della terra, degli alberi, degli animali, degli uomini comuni, degli eroi e infine degli dei, fanno parte di un continuum, che è costantemente ricreato, poiché si origina da un universo in perpetua evoluzione.
A questo concetto si riallaccia l’idea della pluralità dei mondi, del visibile e dell’invisibile, che non devono essere intesi materialmente come luoghi e neppure come un al-di-qua e un al-di-là inconcilabili l’uno con l’altro.
Secondo l’insegnamento druidico, esistevano quattro mondi, o cerchi, che rappresentavano piani diversi della manifestazione del divino. Il primo di questi mondi era il “cerchio vuoto”, l’Oiw, regno dell’assoluto; il secondo era il regno della coscienza spirituale; il terzo era il mondo fisico e reale, dove esiste la morte; il quarto era il mondo della materia inanimata ed incosciente, punto di partenza del processo evolutivo, che poteva ricondurre all’Oiw.
I druidi, sacerdoti e saggi, insegnavano in primo luogo il rispetto per la natura, non tanto per una forma di ecologismo ante litteram, ma perché concepivano la natura come madre sacra di tutti i viventi. Questo pensiero di fondo faceva sì che, per i Celti, non avesse alcun senso la distinzione tra sacro e profano, materia e spirito, corpo e mente, e che la molteplicità sperimentata dai sensi potesse essere ricondotta facilmente ad un principio unitario.
Questo principio unico e increato era appunto l’Oiw, che era circondato da gerarchie celesti che si manifestavano attraverso le forze della natura.
Il Sole era il simbolo visibile dell’Oiw ed emanava tre raggi, tre forme di energia, da cui dipendeva l’ordine dinamico del cosmo: amore, forza, conoscenza. La materia era ciò che portava testimonianza di questo dinamismo, con le sue svariate forme ed i suoi diversi aspetti.
La ricerca di una via che consentisse all’uomo il passaggio dal mondo fisico, caratterizzato dalla legge della necessità, al mondo spirituale, libero e sciolto da ogni legge immanente, comprendeva il superamento di molte prove e possiamo considerarlo uno dei punti fondamentali della cultura celtica, ed è, tra l’altro, alla base della leggenda del Graal.
Derivata da questa concezione del mondo è l’idea che i Celti avevano della morte: secondo la loro interpretazione la morte fisica non era che la cessazione della cooperazione organica tra i quattro elementi, perciò il corpo astrale di un defunto entrava in un mondo invisibile, considerato un’espansione di quello fisico reale, dove conservava la memoria della sua vita terrena. Secondo la tradizione questa memoria spingeva i defunti a ritornare fra i vivi, che li accoglievano serenamente e senza paura o dolore, nel giorno di Samhain (1° novembre). Questa tradizione è stata recuperata dal calendario cristiano nella festa del Giorno dei Morti, il 2 novembre.
Con il passare del tempo la coscienza della vita terrena si affievoliva nei defunti, che giungevano ad una seconda morte, dopo di che potevano accedere alla terza, il mondo dell’oblio. A questo punto, secondo il livello di evoluzione spirituale raggiunto durante la vita fisica, passavano al piano della coscienza spirituale e all’immortalità, oppure ritornavano al mondo fisico. Questo ciclo secondo i Celti sarebbe continuato fino a che l’ultimo essere non avesse raggiunto la perfezione e fosse quindi riunito all’Oiw.
E’ facile capire il motivo per cui Cesare riferisce che i Celti credevano nella reincarnazione, anche se sembra piuttosto che solo alcuni saggi, particolarmente avanzati nella conoscenza della verità, avessero la possibilità di sperimentare diversi stati spirituali. Si spiegherebbe così anche l’insistenza di molti miti sulla capacità di trasformarsi magicamente in animali, cose o persone diverse: tutto farebbe parte dell’esperienza, collegata al perenne e dinamico divenire dell’Oiw.
Secondo la tradizione l’Oltretomba sarebbe un’isola situata all’estremo occidente, oltre l’oceano. Per le popolazioni del Galles, invece, le anime dei defunti dimoravano sull’isola di Avalon, luogo in cui crescevano i frutti che donavano l’eterna giovinezza, l’immortalità e la scienza. Dal momento che i Celti praticamente non ponevano barriere tra il visibile e l’invisibile, questo mondo era facilmente accessibile ai vivi, che credevano di conoscerne le entrate, solitamente poste su colline, vicino a torrenti o nei boschi, tanto che si consigliava ai bambini di non avvicinarsi a questi luoghi, così come anche agli ammalati ed ai deboli, per timore che non avessero energie sufficienti per tornare indietro e vi si smarrissero.
All’Oltretomba è collegato il Sidh, ma tra i due luoghi vi sono alcune differenze sostanziali. Sidh significa “pace”, ma anche “collina incantata”, cioé un luogo abitato da esseri invisibili e fatati, che possono normalmente e facilmente accedere ai due mondi, mentre questo passaggio è casuale e in un certo senso pericoloso per gli esseri umani normali. Il Sidh è un mondo felice e gioioso, dove non esistono sofferenze e bisogni e la vita trascorre tra piaceri di ogni tipo. Si trova in ogni luogo e in nessuno contemporaneamente e potrebbe anche essere inteso come il mondo al quale giunge il defunto dopo la terza morte, a patto che in terra sia riuscito a raggiungere il massimo livello di coscienza.
Al Sidh, luogo di delizie e di piaceri, è collegata tuttavia anche l’idea di esilio: qui infatti si rifugiarono i Tuatha de Danaan, quando, dopo aver respinto quattro invasioni nemiche, non riuscirono a fronteggiare l’ultima, condotta dai figli di Mil. Si ritirarono quindi nel Sidh, immortali ma sconfitti.
Quattrocento divinità sono state enumerate, ma la religione celtica ci appare profondamente unitaria: come non ricordare a questo proposito l’induismo, con il suo dio unico attorniato da circa tre milioni di dei?
Le notizie su questo pantheon celtico ci sono in massima parte fornite da Cesare, che dedica alcuni capitoli del suo De bello gallico alla religione delle Gallie, e dai monaci irlandesi, che, subito dopo la cristianizzazione della regione, misero per scritto le tradizioni fino ad allora tramandate oralmente, come era l’uso dei Celti. Anche se queste informazioni potrebbero in qualche misura essere state alterate ideologicamente, tuttavia ci permettono di ricostruire, almeno in parte, la religione celtica e di tracciare una specie di mitologia comparata.
Il dio più vecchio, Dispater secondo i Romani, fu spodestato da una generazione di dei più giovani, Lug, Karidwen e Dagda, aggressivi ed ambiziosi, proprio come nella mitologia greca accadde ad Urano.
Secondo Cesare, Lug corrisponderebbe a Mercurio ed avrebbe una certa supremazia sugli altri dei. A Lug erano dedicate due della maggiori festività del calendario celtico ed il suo nome è il più ricorrente nei toponimi (Lugdunum per esempio, diventata Lione). Oltre agli attributi dell’Hermes-Mercurio greco-romano, possiede molti degli attributi di Apollo e sempre a Lug sarebbero connessi Keraunos, il dio cornuto, Taransi o Taraunos, il dio delle tempeste, e Belenos, il luminoso.
A Lug era associata, come ad Apollo Artemide, Karidwen, che rappresenta l’archetipo della grande madre, persino superiore a Lug stresso, e che indica la sopravvivenza nella società celtica della concezione matriarcale del divino. Karidwen, nella persona di Artio, diviene la dea della natura intonsa e selvaggia, ed appare nella forma di un’orsa (artos significa orso, come è ricordato nel nome del mitico Artù).
Nella forma di Epona, la dea cavalla, conferisce la sovranità ed è estremamente interessante notare come il potere giunga all’uomo tramite una divinità femminile, così come in tutte le favole indoeuropee l’eroe deve sposare la figlia del re per raggiungere la regalità. Epona, inoltre, può prendere la forma di un fiume in piena, riallacciandosi all’idea della fertilità. Altre personificazioni di Karidwen erano Rhiannon, la regina della morte, Morrigain, la maga, Coventina, collegata ai pozzi sacri e regina della poesia e dell’arte profetica, ed infine Brigid o Brigt, la brillante, cristianizzata come Santa Brigida e ancora oggi molto onorata in Irlanda.
Karidwen, la dea madre, era anche associata in modo particolare con la luna e comprendeva le tre forme di questa: la Vergine (luna nuova), la Madre (luna piena) e la Maga (luna calante).
L’ultima divinità della triade principale è Dagda, dio degli inferi, simile ad Ade, ma con caratteristiche anche di Poseidon, inoltre è rappresentato zoppo, quindi può far pensare anche ad Efesto. Non dà origine a molte altre divinità, ma Cesare afferma che era oggetto di grandissima venerazione.
Uno dei punti più interessanti della mitologia celtica è quello che potremmo chiamare la “dominante notturna”. La maggior parte dei riti, infatti, si svolgeva durante la notte e le ore dopo il tramonto del sole, o subito prima dell’alba, erano considerate le più propizie per leggere il futuro. Dal momento che il sole era considerato il simbolo visibile dell’Oiw e il centro di ogni perfezione, questo fatto sembrerebbe essere una contraddizione.
In realtà è perfettamente logico, se consideriamo il modo di vivere e concepire il sole che avevano i Celti: infatti ne coglievano anche le caratteristiche distruttive, come le siccità terribili, che dal XIII secolo a.C. in poi avevano devastato l’Europa e che probabilmente erano rimaste nella memoria collettiva della popolazione, dando vita al grande rispetto religioso per l’acqua (fiumi, laghi, stagni: tutti erano considerati sacri), considerata elemento principale di fertilità; per la terra, fecondata dal sole, ma madre effettiva di tutte le creature; per la luna, collegata al ciclo eterno di nascita, morte e resurrezione.
Per chiarirne ancora il ruolo, si consideri che per i Celti il sole, dopo il tramonto, compiva un viaggio agli inferi, nel mondo delle tenebre e riappariva all’alba del giorno successivo dopo “aver fatto morire” le stelle.
E’ importante ricordare ancora che Karidwen, che incarna l’archetipo materno, quindi è a tutti gli effetti una dea madre, presenta immagini di luce e immagini di tenebre insieme, secondo la dicotomia tipica di queste dee, datrici di vita ed allo stesso tempo di morte.
Anche Dana, madre dei Tuatha de Danaan, la popolazione divina rifugiatasi nel Sidh, è collegata con la luna e sembra essere in relazione con la Diana italica, che, prima di essere identificata con la greca Artemide, aveva la supremazia sul dio del sole stesso.
Questi sono solo alcuni esempi, tuttavia potrebbero essere sufficienti a spiegare il fenomeno delle “Madonne Nere”, che troviamo sparse su tutti gli antichi territori celtici, dall’Irlanda, alla Francia (Chartres, Vichy, Le Puy, Marsiglia) all’Italia del Nord (Oropa, Madonna della Neve, Loreto): si collegherebbero ai tre aspetti di Karidwen (vergine, madre, maga), l’aspetto femminile dell’Oiw, che era venerata dai Celti comer Dea Bianca (la luna nuova) e come Dea Nera (la luna calante), dea della morte e della profezia.
Le numerose divinità celtiche devono essere interpretate alla luce di una profonda identificazione con la natura, tanto che il contatto con il divino si effettuava nei boschi, sulle alture, presso i laghi o gli stagni, le sorgenti, le grotte, che permettevano di avvicinarsi al grembo della terra. Il bosco era il luogo sacro per eccellenza, anche se menhir, dolmen e cromlech venivano usati nei riti perché segnalavano la via più diretta verso dio, scoperta dagli antenati che per primi avevano abitato quei luoghi.
Il simbolo dell’albero della vita è presente praticamente in tutte le tradizioni mitologiche e rappresenta l’esistenza nella sua totalità, essendo il prodotto dell’unione tra la terra, dove affondano le sue radici, e il cielo, dove si espandono i suoi rami. L’albero, maschile nel suo tronco, ma femminile nella sua capacità di generare frutti, riunisce in sé i due sessi e come ogni immagine androgina è un simbolo di unità.
I Celti, con la loro particolare idea spirituale della natura, attribuirono all’albero un ruolo importantissimo nella loro visione del mondo e nelle loro pratiche religiose.
Tempio degli dei e luogo privilegiato per i culti era il bosco e nelle sue radure i druidi impartivano i loro insegnamenti.. Una delle piante che erano considerate particolarmente significative era la quercia, il cui nome in gaelico significa anche “porta”. Infatti la sapienza druidica permetteva di superare l’esperienza puramente fisica della realtà e di raggiungere la consapevolezza spirituale creando in questo modo un varco, una “porta” quasi, tra i due mondi e gli alberi, la quercia in particolare, agivano da catalizzatori delle energie psichiche. La quercia era anche associata a Brigid, che come Santa Brigida è ancora particolarmente onorata a Kildare, il cui nome significa in irlandese “chiesa delle querce” a Taransi, il dio del fulmine; a Dagda, che possedeva una mazza costruita con legno di quercia, per mezzo della quale apriva per i vivi la porta della morte e al contrario poteva riaprire la via verso la vita per i morti.
Un’altra pianta sacra ai druidi era il vischio, considerato un’emanazione celeste, perché come parassita della quercia non ha bisogno di radicarsi in terra. Il vischio era usato in relazione ai riti del cambiamento del ciclo annuale, in questo caso il solstizio d’inverno, dal momento che è una delle pochissime specie che germoglia nella stagione fredda, in cui la terra sembra morta.
La betulla era considerata un simbolo del femminile, per l’aspetto lunare della sua corteccia, oltre che simbolo della conoscenza e della creatività.
Il salice e l’ontano indicavano i poteri della luna e dell’acqua, ed erano considerati fonte di ispirazione poetica, mentre il nocciolo, flessibile, resistente e produttore di frutti molto nutrienti, rappresentava la saggezza. Il tiglio, invece, era simbolo dell’amore coniugale e dell’amicizia.
Quercia, vischio, betulla, salice e ontano rappresentavano per i Celti l’archetipo femminile, mentre quello maschile era rappresentato da alberi che avevano frutti rossi, il colore del sangue e del fuoco.
Uno era il sorbo, i cui frutti, con le mele e le noci, erano considerati divini. Sempre al sorbo era collegato il potere della divinazione e la capacità di proteggere dagli incantesimi negativi e dai fulmini. Assimilati al mondo degli uomini e dei guerrieri erano l’agrifoglio e il frassino, usato per costruire armi.
L’abete era considerato l’albero della nascita per eccellenza, simbolo che si è conservato nella tradizione natalizia attuale. Anche il melo selvatico era considerato particolarmente sacro e lo si trova menzionato molto sovente nei miti e nelle leggende.
Pur senza dar vita ad una dicotomia drastica, esistevano anche alberi che possedevano un potere negativo e tali erano il tasso ed il sambuco. Il tasso era associato alle tenebre ed alla morte, perché con le sue foglie i guerrieri facevano una poltiglia velenosa e vi intingevano le frecce: nel medioevo il tasso si trova costantemente associato alla stregoneria.
Il sambuco, invece, incuteva paura non tanto perché si diceva crescesse presso le vie di ingresso del Sidh, ma perché a causa delle sue bacche nere ricordava l’aspetto oscuro della dea della luna ed il suo potere mortale.
Anche le manifestazioni più umili del mondo vegetale erano circondate da significati sacrali, come ad esempio il giunco, perché collegato alla fertilità dell’acqua, la ginestra, che arricchisce i terreni poveri, l’erica, il cui polline produce un ottimo miele, e infine il trifoglio, oggi simbolo dell’Irlanda, e anticamente caro in modo particolare ai druidi, come manifestazione compiuta della triade divina.
I druidi controllavano la vita pubblica e privata del popolo ed insieme con i cavalieri erano considerati al vertice della società.
Le loro prerogative erano vastissime: presiedevano non solo ai culti, ma anche esercitavano la loro autorità nella sfera morale e in quella culturale. Erano sacerdoti, indovini, interpreti dei segni divini, giudici, maestri e uomini di scienza e sarebbe senz’altro troppo riduttivo definirli semplicemente sacerdoti, o, come alcuni vorrebber0, primitivi sciamani.
Il druidismo costituì una caratteristica del tutto originale del mondo celtico e fu un elemento unificante in mezzo al particolarismo tribale delle numerose popolazioni che si estendevano dall’Europa del Nord alla Galizia. Cesare ci riferisce che la gente accorreva in gran numero presso le scuole druidiche (l’insegnamento avveniva all’aperto, sovente nei boschi) e che alcuni restavano alla scuola anche dopo i vent’anni.
La trasmissione del sapere era prevalentemente orale e basata sull’esercizio della memoria. Lo scopo principale dell’insegnamento era la conoscenza della natura, delle sue energie telluriche e cosmiche, delle sue leggi e dei suoi ritmi. Questo tipo di insegnamento creava un rapporto molto intenso, rispettoso e armonioso con la natura e l’ambiente, che può trovare paragone solo con la cultura delle Prime Nazioni del Nord America.
Ho iniziato parlando di miti celtici, ma non ne ho parlato per nulla, né li ho riassunti o commentati: questo perché ho preferito mettere un poco di ordine nelle poche informazioni dirette che si hanno del mondo spirituale celtico, in modo da evidenziare quale fosse la concezione della vita e dell’esistenza in generale che avevano questi nostri antenati, troppo spesso messi da parte e quasi dimenticati in favore della gloria di Roma e delle culture successive.
Ho cercato di scoprire il significato dei miti, di interpretarli, di estrarne l’anima più riposta, in modo da ricavare un quadro, forzatamente incompleto, del sistema ideologico celtico.
BIBLIOGRAFIA
Agrati, G. M.L. Magini. I racconti gallesi del Mabinogion. Milano: Xenia, 1982.
De Galibier, J. I Celti. Aosta: Keltia, 1009.
—. I Druidi. Aosta: Keltia, 1998.
Frazer, J. Il ramo d’oro. Torino: Boringhieri, 1996.
Gregory, Lady. Cuchulain of Muirthemne. New York: University Press, 1970.
—. Gods and fighting men. New York: University Press, 1970.
Hetman, f. Fiabe celtiche. Milano: Mondadori, 1996.
Kruta, V. E V.M. Manfredi. I Celti in Italia.Milano: Mondadori, 2001.
Layard, J. I Celti alle radici di un inconscio europeo. Milano: Xenia, 1995.
Maclean, M. The Literature of the Celts. Reading: Cox & Wyman, 1998.
Markale, j. Il druidismo. Milano: Mondadori, 1995.
Rolleston, T.W. I miti celtici. Milano: Tea, 1998.
Vasconi, M. Miti dei Celti. Colognola ai Colli (VR): Demetra, 1999.