Terza parte dell'articolo di Musashi
Seguendo il filo dell’esposizione precedente, soprattutto i sospetti passaggi di Ippolito, veniamo all’esistenza di una tradizione segreta all’interno del cristianesimo in epoca patristica. L’esistenza di un “cristianesimo misterico” è ormai abbastanza accettata persino dalla critica ufficiale (si mettano l’anima in pace i bravi cattolici) sebbene la materia presenti numerosi e irrisolti interrogativi. In ogni caso la storiografia sul cristianesimo ha dovuto ammettere come dato indiscusso la presenza, in seno ai primi secoli della Chiesa, di una disciplina arcani, che prevedeva l’insegnamento delle dottrine in maniera progressiva ai catecumeni, secondo la modalità delle religioni misteriche (storico il saggio di Hatch del 1888 Influenza delle idee greche ed usi alla Chiesa cristiana). Anche la messa anticamente era divisa in due parti: la prima alla quale poteva accedere il catecumeno, e la seconda che era riservata ai soli iniziati ai misteri cristiani (quando ancora il battesimo poteva avere la connotazione di un rito iniziatico).
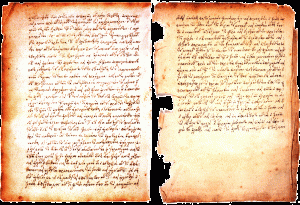
La lettera di Mar Saba in cui Clemente alessandrino conferma l’esistenza di un vangelo segreto di Marco
Ecco dei riferimenti nella Patristica greca: S. Giovanni Crisostomo (in I Cor. hom., XL, 1) dice: “vorrei parlar chiaramente, ma non oso a causa dei non iniziati“.
Ecco dei riferimenti nella Patristica greca: S. Giovanni Crisostomo (in I Cor. hom., XL, 1) dice: “vorrei parlar chiaramente, ma non oso a causa dei non iniziati“.
San Basilio esplica che:
“Dei dogmi e Kerygmata , che sono tenuti nella Chiesa, riteniamo alcuni dall’insegnamento scritto e alcuni ci derivano dalla tradizione apostolica, che erano stati tramandati en mystèrio. E entrambi hanno la stessa forza nelle materie di religione [...] Essi provengono dalla tradizione silenziosa e mistica, dall’insegnamento segreto e non pubblicabile” (de Spiritu Sancto, 66).
Se questi aspetti segreti vertevano sugli elementi del rito, cosa certa dato che esso era riservato in quanto missa fidelium, non possiamo sapere quali altri elementi questi segreti orali coprissero, e se vi fossero dottrine interne che andavano oltre il dogma cristiano quale è stato divulgato in pubblico.
Del resto il fatto che fosse non-scritto indica qualcosa in più rispetto ai dogmi che sono stati scritti e insegnati come catechesi. Questa segretezza rispetto non solo ai sacramenti ma persino alle dottrine, alcune delle quali solo oralmente non a tutti potevano essere divulgate, è ribadita anche da San Cirillo di Gerusalemme.
Invece i padri della chiesa latina come Agostino o Ireneo smentiscono che vi fossero tradizioni apostoliche segrete, e che vi fosse bisogno di un insegnamento esoterico. E’ inutile negare che –malgrado la tendenza all’unità della Chiesa- vi fossero in realtà due Cristianesimi.
Ormai è appurata l’autenticità della “lettera di Mar Saba”, ritrovata negli anni ’80, fatta sparire dal patriarcato ortodosso di Gerusalemme, ma fortunatamente presente in copia fotografica.
Al di là di ogni altro brano citato dai padri orientali, questo testo è fin troppo esplicito. San Clemente d’Alessandria (siamo ancora quasi in epoca “apostolica”) risponde al suo discepolo Teodoro che l’apostolo Marco scrisse addirittura due vangeli di cui uno segreto. Esso sarebbe conservato nella sua diocesi di Alessandria. I Carpocraziani ne avrebbero una copia modificata e corrotta.
Tuttavia la provenienza apostolica di questa tradizione segreta era certa per Clemente:
“egli (Marco) non ha divulgato ciò che non deve essere pronunciato, né ha scritto della ierofania dell’insegnamento del Signore…”.
Queste verità esoteriche, di cui Marco avrebbe solo accennato l’esistenza, condurrebbero l’ascoltatore -dice san Clemente- nel “santuario più intimo della verità nascosta dai sette veli”. Peraltro neanche questo vangelo segreto dice tutto, ma si limiterebbe a testimoniare una ierofania e la presenza di un trasmissione orale, ma senza profanare questo mistero.
Quanto alle manipolazioni carpocraziane… Clemente sembra quasi ammettere che la pozione dei Carpocraziani fosse vera, e andasse nascosta per quanto più fosse vera. Dice:
“Perché, anche se dicono qualcosa di vero, chiunque ami la verità non dovrebbe, anche così, essere mai d’accordo con loro. Perché non tutte le cose vere sono la verità, né quella verità che sembra vera solo secondo opinioni umane va preferita alla verità vera, secondo la fede”.
Come a dire: “non dico che hanno torto, ma per verità di fede noi dobbiamo comunque smentire!”
E’ davvero un’affermazione compromettente.
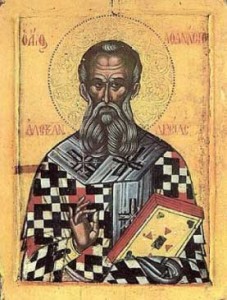
San Clemente alessandrino
In ogni caso tradizioni segrete vi erano, ed avevano origine apostolica, o almeno tale era ritenuta dai Padri greci e orientali. Tuttavia, intorno al IV secolo (siamo negli anni del concilio di Nicea), questa tradizione esoterica, prima chiaramente attestata almeno presso alcuni Padri, sembra iniziare un periodo di abbandono. Gregorio di Nissa (335-395) scrive: “Al giorno d’oggi questa tradizione [segreta] non viene più osservata in molte chiese” (Vita Mosis II, 160). Infine, dal IV secolo in poi non si hanno più tracce di un insegnamento segreto, né nelle lettere, né nelle omelie dei Padri della Chiesa.
Considerando questi primi tre secoli e mezzo, ritengo verosimile che vi fossero quattro diverse categorie di membri del clero, con atteggiamenti diversi nei confronti della tradizione esoterica cristiana:
1) una parte che nulla sapeva di queste trasmissioni segrete (se non limitandosi a celebrare la seconda parte del rito escludendo i catecumeni). Non solo, ma essi ritenevano ridicolo che esistesse una rivelazione segreta. S. Agostino irride a questa affermazione, per lui non è vero che svelare un insegnamento a chi non è pronto lo possa danneggiare. E’ una sciocchezza: non può succedergli nulla! Del resto, se Agostino non fosse stato così incapace di comprendere il senso del Mistero non avrebbe abbandonato il Manicheismo. Sant’Ireneo (Adversus haereses III,3,1), definisce un delirio che gli Apostoli avessero trasmesso in segreto una parte della rivelazione solo ad alcuni vescovi… evidentemente dimenticando come gli stessi vangeli più volte facciano intendere un insegnamento segreto e uno aperto (Mc 4,12-13). In effetti c’è anche una componente umana in Ireneo: il rozzo e barbaro vescovo delle Gallie, geloso, che nega una trasmissione che non ha potuto ricevere.
2) Color che negano apertamente ogni segreto, condannano come eretico chi ne parla, ma forse ne è a conoscenza e forse anche iniziato. Vedasi la strana affermazione di Ippolito (cfr. parte II di questo saggio).
3) Coloro che, all’interno della Chiesa ufficiale, rivendicano esplicitamente una tradizione apostolica segreta.
Origene (C.Cels, VI, 6,76) scrive con orgoglio: “gli apostoli sapevano meglio di Platone quali verità dovevano mettere per iscritto e come dovevano essere scritte, e quali quelle che non dovevano essere scritte per nessun motivo destinandole alla moltitudine; ciò che deve essere detto e ciò che non è di questa natura”.
San Clemente non è da meno e, smentendo Ireneo, afferma:
“dopo la resurrezione il Signore trasmise la tradizione della gnosi a Giacomo il Giusto, a Giovanni, e a Pietro, questi agli altri apostoli e loro ai Settanta, fra cui Barnaba” (Euseb. Hist. eccles. II,1,4).
Anche costoro, difensori di una “gnosi ortodossa”, si schierano però contro le altre scuole gnostiche che denunciano come “eretiche”. In fondo l’atteggiamento di 2) e 3) è simile: coloro che mostrano di possedere un esoterismo sono potenzialmente dei nemici. Tuttavia il gruppo 2) ne nega l’esistenza, il 3) che poi fa capo alla Chiesa di Alessandria non ha timore di ammettere che esiste una tradizione apostolica segreta, ma ne rivendica il monopolio contro altre scuole gnostico-cristiane. In effetti vi sono due diverse Chiese, con cristianesimi simili solo nell’aspetto esteriore: il gruppo 1) è la Chiesa latina, il gruppo 2)e 3) è la Chiesa greca ed egiziana.
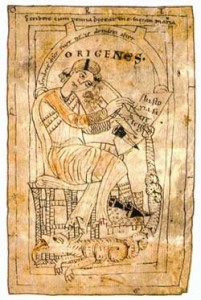
Origene
Vi è infine il gruppo
4), le varie scuole gnostiche autonome. Molte di queste facevano ancora parte però del “corpo della Chiesa”. E soprattutto anche esse possedevano la successione apostolica, si fondavano sugli stessi vangeli (anche canonici) seppur interpretati in chiave allegorica e non solo storica. Alcuni dottori gnostici erano vescovi e il più famoso, Valentino, fu quasi eletto papa. Una bella difficoltà per i sostenitori della non-ortodossia dello gnosticismo cristiano.
Quale era il motivo per cui anche i sostenitori di 3) (Clemente, Origene, Cirillo di Gerusalemme, S. Giovanni Crisostomo) criticavano gli “eretici” gnostici non meno di quanto facessero i loro omologhi Padri latini?
A mio avviso costoro (Padri orientali), possedeva realmente la trasmissione esoterica risalente al Cristo, così come i maestri gnostici del tipo di Bardesane, Eracleone, Basilide e Valentino. Questo si riscontra in una analoga tendenza alla lettura allegorica dei testi, e nel sostegno a tutta una serie di dottrine che poi vennero bandite dai concili e dal cristianesimo ufficiale, dottrine appunto di tipo gnostico o platonico-gnsotiche.
Perché allora anche loro schierati contro gli eretici?
Va detto che questi dottori della Chiesa orientale forse potevano essere depositari solo di una parte di quella trasmissione segreta; così questo possesso parziale spiegherebbe la loro riluttanza ad accettare dottrine che erano tradizione per altri gnostici cristiani – i quali avevano la totalità della trasmissione- ma non per loro. In effetti, come al solito, chi possiede il più comprende chi possiede il meno, chi possiede il meno non può comprendere chi possiede il più. E’ una legge costante dell’esoterismo di tutti i tempi (fenomeni analoghi vengono descritti nei testi buddhisti che parlano di trascendenti assemblee di bodhisattva nel piano sambhogakaya in cui alcuni membri meno evoluti risultano sconcertati dalle conoscenze dei loro superiori che appaiono loro eretiche).
Tuttavia vi può essere un secondo elemento di minor buona fede da parte di Clemente e degli altri, fattore che accennai nel mio articolo su Paolo di Tarso e la Gnosi. I gruppi di gnostici cristiani (valentiani, basilidiani…) rappresentavano un elemento difficilmente controllabile. Assai difficilmente un detentore di una trasmissione esoterica, che poteva anche essere un Realizzato, si sarebbe sottomesso all’autorità spesso solo esteriore di un pontefice o di un gruppo ecclesiale… che spesso neanche sapevano di quelle verità.
Questi gnostici “integrali”, alcuni dei quali erano effettivamente dei Maestri Realizzati (dei parahamsa, si direbbe nell’induismo) erano a tutti gli effetti dei Christi. In quanto tali essi avevano trasceso ogni gerarchia umana (anche se spiritualmente fondata). La loro realizzazione autonoma, basata solo su una trasmissione apostolica diretta e sull’ascesi individuale, poteva essere ugualmente trasmessa o innescata in altri, in maniera diretta e non mediata, secondo un lignaggio non ecclesiale ma diretto (di tipo “yogico”). L’intrinseca autocefalìa di questo processo avrebbe minato sin dall’origine l’unità della Chiesa.
Se non fossero stati eliminati fisicamente (loro e i loro documenti segreti, apocrifi), il potere di questi dottori gnostici avrebbe prima o poi compromesso lo sviluppo del cesaropapismo ecclesiale, in un fiorire di scuole ognuna legittima, ognuna in pace con le altre, e sostanzialmente paritarie, confederate. In effetti il cattolicesimo si è incarnato come la rivincita dei gruppi ebraici o giudeo-cristiani nel creare una struttura burocratica e imperialista contrapposta a quella dei loro “oppressori” romani. O meglio fu il meccanismo attraverso cui l’ebraismo si impadronì della macchina burocratica dell’impero romano.
Se avessero prevalso gli gnostici, invece, il cristianesimo oggi avrebbe assomigliato più o meno all’induismo, con una diversità di scuole e correnti, spesso anche distanti formalmente, ma correlate su un impianto di fondo condiviso e con dei testi di riferimento comuni (Veda e Upanishad, smrti e shruti), ma senza forme oppressivo-coercitive e autorità militarmente armate, o un potere di controllo centrale.
Anche i Padri orientali, tuttavia, seppure detentori anche solo parziali di una trasmissione gnostica, dal momento in cui accettarono come prioritaria l’edificazione di una unità politica, optarono per il potere di Questo Mondo.
Sulla scorta di queste premesse, torniamo ora al periodo apostolico.
Ho fin qui ipotizzato la presenza di una corrente misterica “ellenistica” all’atto fondativo del cristianesimo, misteri ai quali anche Gesù doveva essere iniziato. Ho cioè sostenuto che, sebbene lo sfondo su cui ci si muoveva era esteriormente ebraico, doveva esserci un gruppo (da identificarsi nei seguaci del Battista, forse i Nazorei) che segretamente coltivasse un qualche tipo di mistero pagano o sincretico ebraico-pagano.
Ciò si fonda essenzialmente sulla presenza di tratti chiaramente non derivabili da tradizioni ebraiche. Del resto, come dissi, il fatto che il “fondatore” del cristianesimo sia incorso nell’ostilità dei rappresentanti ufficiali dell’ortodossia ebraica, si spiegherebbe molto bene riconoscendo che le radici cristiane non coincidevano esattamente con quelle ebraiche.

Mano di Sabazio. Da notare le tre dita alzate, come nella liturgia cristiana
Le premesse di questa confluenza sono da comprendersi nello spirito del tempo. Nell’evo antico era forte la tendenza comparatistica a cercare, tra i culti nazionali, corrispondenze nelle varie forme esteriori (es. correlazione Mercurio-Hermes, o Hermes-Toth). Da questo atteggiamento, che esplose poi nel periodo tardo antico, non sfuggì anche l’ebraismo… si creò così un importante filone di magia ellenistico-romana, quello che va dai Caldei babilonesi ai filosofi teurghi della tarda-antichità, che aveva inserito nel proprio pantheon e nel proprio dottrinario segreto la figura del dio ebraico, identificato con Kronos. Così il filone sincretico (o più correttamente “comparativo”) aveva stabilito il parallelismo Kronos-Yahweh. Anche Varrone reatino afferma che “il dio dei Giudei è chiamato Iaô dai Caldei nei loro scritti segreti” (Rer.div. I, fr.17 Card.). Altre assimiliazioni furono tra Serapide o (Giove Serapide) e lo Jahweh (pronunciato Iao in greco): un’ iscrizione ritrovata in Spagna è dedicata a Zeus-Serapide-Iao (Perera, Ebenes, El sello de Dios, pp.58-59).
Ovviamente i già detti Samaritani furono il canale privilegiato di questa osmosi nel senso di recezione, anche in ambiente ebraico, di dottrine religiose o magico –sincretiche di origine caldea.
La koinè creata dal periodo ellenistico ampliò certamente questi scambi ad ambiti non solo caldei o babilonesi.
Di questi interscambi si “giovò” anche il mysterion di Sabazio frigio, come sostenne Cumont. Del resto la semplice assonanza, forse non casuale, fra Juppiter Sabatius e Jahweh Sabaoth favorì la fusione delle due divinità.
Così potremmo non stupirci se parte del culto misterico di Sabazio fosse in qualche forma seguita anche in margine al mondo ebraico (peraltro assai ostile a influssi esogeni). Di certo i cristiani mutuarono dal culto di Sabazio la mano benedicente con le tre dita alzate, simbolo del dio frigio o ebraico-frigio. Da notare di sfuggita che nella mano pantea di Sabazio fa spesso capolino un serpente. Nelle iniziazioni di Sabazio veniva introdotto un serpente aureo nella scollatura della veste dell’iniziando e di sicuro la drammaturgia del serpente doveva avere un particolare significato in quel culto.
Tuttavia io ritengo che i misteri di Sabazio siano tutto sommato una componente secondaria o indiretta nel processo di fondazione del cristianesimo.
Nella prossima parte esporrò più chiaramente quali le fonti storiche di questi misteri….
Nessun commento:
Posta un commento